Cosimo Burgassi
«Chiedere a lingua»: Boccaccio e dintorni
L’analisi prende le mosse dalla descrizione di Guido Cavalcanti nel Decameron di Giovanni Boccaccio: «oltre a quello che egli fu un de’ migliori loici che avesse il mondo e ottimo filosofo naturale [...], sì fu egli leggiadrissimo e parlante uom molto [...] e con questo era ricchissimo, e a chiedere a lingua sapeva onorare cui nell’animo gli capeva che il valesse» (VI 9, 8). Sulla scorta di questo celebre passo, la locuzione chiedere a lingua gode di una certa fortuna nella letteratura del Rinascimento maturo, in autori che riflettono l’espressività della tradizione linguistica fiorentina più schietta: Antonfrancesco Grazzini, Benedetto Varchi, Benvenuto Cellini, Annibal Caro, Bernardo Davanzati.
ll contributo ripercorre la storia di questo modulo fraseologico, indagandone i contesti di ricorrenza e precisandone, di volta in volta, il significato nel quadro sintattico, alla luce in particolare delle traduzioni dei testi classici.
Per la fase antica lo studio tiene conto dei numerosi commenti al Decamerone e offre nuovo materiale documentario, soprattutto con riferimento al volgarizzamento della Terza decade di Tito Livio, particolarmente rilevante per la comprensione della formula in esame.
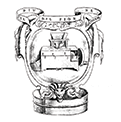 Accademia della Crusca
Accademia della Crusca