Stefano Telve
L'oralità parlamentare trascritta (1861-1921): un modello di lingua istituzionale moderna
La pratica del resoconto stenografico nasce per corrispondere al principio di pubblicità dei lavori parlamentari: gli oratori si rivolgono non solo ai colleghi e agli elettori, ma più in generale ai mass media, e assumono atteggiamenti stilistici differenti. Di là dalle tecniche e dalle scelte adottate dal singolo stenografo all’atto della trascrizione, la versione scritta (cioè trascritta, revisionata e infine pubblicata) dei loro discorsi ha una veste istituzionale e ufficiale e, in quanto tale, rappresenta un campione di lingua che “fa testo” e “fa norma". La Camera dei deputati si presenta dunque come laboratorio e insieme cassa di risonanza pubblica di un’oratoria certamente classicheggiante (composta da voci ed espressioni colte e letterarie) ma al tempo stesso anche molto moderna, prontissima ad accogliere sia espressioni tecniche e specialistiche, anche straniere, di conio recente o quasi inedite, sia espressioni colloquiali, correnti nella conversazione colta. Il resoconto stenografico, qui indagato per gli anni 1861- 1921, risulta dunque essere una fonte autorevole che a partire da metà Ottocento comincia a proporre per via scritta, a un pubblico ampio − o anche, potremmo dire, a un’opinione pubblica in via di formazione − un modello di riferimento di oralità colta e moderna in lingua italiana.
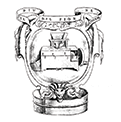 Accademia della Crusca
Accademia della Crusca