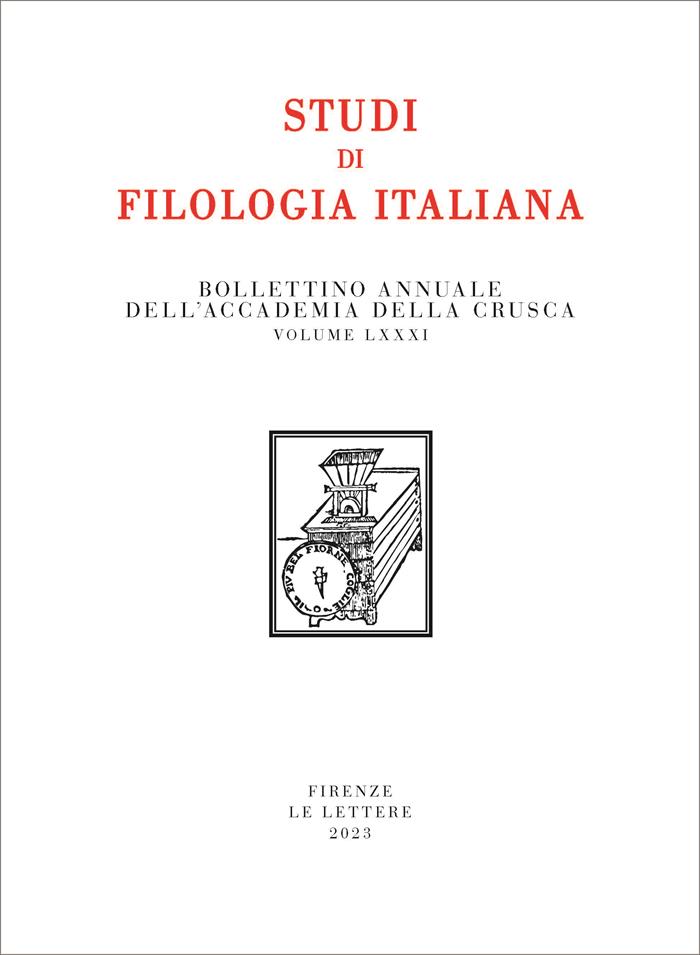Lorenzo Giglio
Lorenzo Bartolini copista di rime antiche: nota sul «Texto del brevio»
Il contributo muove dal riconoscimento della mano di Giovanni Brevio nelle postille del Palatino 204 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e dimostra che il canonico veneziano ebbe un ruolo tutt’altro che secondario nell’allestimento di questo importante testimone della Raccolta aragonese, e forse anche nella sua divulgazione in Italia settentrionale. È infatti noto che da un non meglio identificato «texto del Brevio» Lorenzo Bartolini derivò buona parte dei materiali che raccolse, intorno al 1530, nell’attuale ms. 53 della Biblioteca dell’Accademia della Crusca, che per la sezione di tradizione aragonese è risultato dipendente dallo stesso Palatino. La seconda parte del saggio discute quindi l’ipotesi che proprio nel Palatino sia riconoscibile una delle fonti dell’abate, e pur senza giungere a una conclusione definitiva riguardo a questo punto (in mancanza di prove materiali che documentino il contatto diretto fra i due codici), constata un tasso di innovazione in Bart2 rispetto a Pal1 che non sembra trascurabile, sia per la mole cospicua di varianti che caratterizzano la tradizione bartoliniana, sia per la specifica qualità di gran parte di questi interventi, utili a tracciare una fisionomia più precisa del copista di Bart.
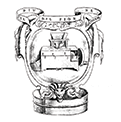 Accademia della Crusca
Accademia della Crusca